Resta attualissimo il libro sul declino della borghesia e dei ceti intellettuali che hanno alimentato uno sguardo su Napoli «costantemente offuscato da indulgenza liricizzante ed egocentrica
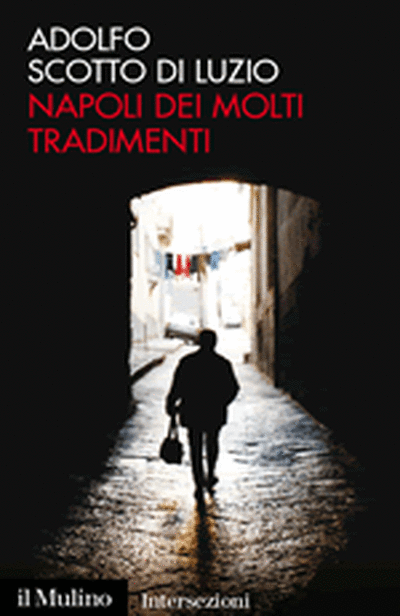
Gli stereotipi e i luoghi comuni
La munezza e l’afasia della borghesia, gli stereotipi ed i luoghi comuni, la camorra e la pizza. L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma è ampiamente nota la difficoltà di Napoli dallo svincolarsi da questa rappresentazione. Oltre però ad interrogarci sul perché o sulle modalità di tali dispositivi narrativi, è necessario spezzare questa cantilena fatalistica, esaminando le origini possibili, le cause ipotizzabili e gli eventuali “responsabili”. Proprio da questi ultimi prende spunto Adolfo Scotto di Luzio in «Napoli dei molti tradimenti» [Il Mulino, 10 euro]. È un testo uscito quasi dieci anni fa (nel 2008), ma come ha ricordato in tempi non sospetti Fabrizio D’Esposito, è ancora attualissimo.
L’illusione sessantottina
Di Luzio è docente alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo ed editorialista del Corriere del Mezzogiorno. Individua i principali responsabili in quella generazione di quarantenni rimasta prigioniera dei miti del ’68. Non solo a causa del retroterra culturale e di tutto l’armamentario ideologico sessantottino – che in realtà si traduceva in un’idea «approssimativa» della politica – ma per una questione di approccio. «L’illusione è stata una modalità decisiva nel rapporto che abbiamo stabilito con la città e la sua storia […] Napoli ci era al tempo stesso estranea ed indispensabile. Tendevamo da un lato a metterla da parte, per quel suo inammissibile tratto plebeo […] Eppure, con le dovute cautele dovevamo stargli il più vicino possibile, perché questo ci dava il senso di una pienezza e insieme era il massimo di avventura che riuscivamo a concederci».
L’amore verso il popolo
L’illusione è stata anche la modalità con cui si è scelto di coltivare l’amore verso il popolo. Una forma dell’immoralità politica secondo l’autore, con cui provare a sciogliere il nodo irrisolto, superare un conflitto insanabile e ottenere il perdono dal peccato originale. Ovvero «unificare ciò che la storia aveva diviso, gli intellettuali e la plebe, e per fare questo c’erano le canzoni e il dialetto. Lo spirito e la voce autentica del popolo».
In tale contesto, ha avuto un ruolo decisivo la letteratura e la tradizione letteraria napoletana – intese come fonte e potente fattore «di legittimazione del fondo popolare della città» – in particolare la Napoli milionaria di Eduardo De Filippo, a cui l’autore contrappone la Napoli borghese di Elena Canino, «quanto di più lontano dal ricatto dell’autentico popolare».
Il fattore P
Quello che possiamo chiamare fattore P è parte integrante dell’identità cittadina, motivo di orgoglio e di ricchezza. Nell’interrogarsi sulla dimensione popolare di Napoli non c’è nessuna tirata snobistica né tentativi abortiti e rimossi di prolofobia, ma più semplicemente il rigetto di degenerazioni identitarie, il rifiuto nell’indossare vestiti – quasi sempre folkloristici e pittoreschi – su misura confezionati da altri.
Un modello di subalternità culturale
È bene chiarire che se da un lato è legittimo respingere i tentativi di rappresentazione unilaterale e monodimensionale, dall’altro proteggersi con «la retorica del paesaggio e la predazione del territorio» appare goffo e controproducente. Soprattutto da parte della vecchia borghesia napoletana e del ceto intellettuale, che per mondare le proprie coscienze ed occultare «il rammarico circa la propria irrilevanza nella determinazione dei destini della città», sono rimasti fedeli alla bellezza cittadina, «espressione nostalgica di quello che non hanno avuto la forza di difendere in tutti questi anni». Non rendendosi conto così di alimentare – mediante langue de bois, la lingua di legno con cui si camuffa la realtà – un modello di subalternità culturale, attraverso la produzione di uno sguardo sulla città «costantemente offuscato da indulgenza liricizzante ed egocentrica».
Ovviamente il contributo della politica non è secondario, anzi. Ciò che rende il testo di Scotto Di Luzio meritevole di lettura e rilettura a distanza di così tanto tempo, è lo sguardo d’insieme sui tradimenti cittadini senza però, pur occupandosene lungamente, rifugiarsi in assolutorie e comode scorciatoie politiche.
Non è questione di amministrazioni
La discussione su Napoli e sulle sue difficoltà non si può ridurre unicamente a questioni di amministrazione politica, proprio perché al territorio è stata «imposta una maschera», la città «oggetto di una pervicace opera di rimozione. Costantemente fraintesa, si è prestata riflettere tutte le fantasie, i sogni, i discorsi velleitari che l’hanno eletta a sfondo pretestuoso dei propri vaneggiamenti».
Cordone sanitario di bugie e inganni
Intorno a Napoli si è costruito un cordone sanitario fatto di bugie ed inganni, una sistematica alterazione dei dati di realtà, un autocompiacimento narcisistico che ha impedito alla città di diventare adulta, di fare i conti con le sue idiosincrasie, addomesticando la fredda verità con bislacche operazioni-simpatia in modo da renderla accettabile ed umanamente, pietosamente, comprensibile. Ogni critica letta, interpretata e vissuta come un pesante atto d’accusa o di lesa maestà, continuamente in bilico tra il servo encomio ed il codardo oltraggio, «incapace ad essere il centro di alcunché, Napoli si rifiuta di guardarsi allo specchio della propria marginalità».
Accusato di essere spargitore di fango
Il libro di Scotto di Luzio potrà essere banalmente liquidato come il solito j’accuse firmato dal solito spargitore di fango, in realtà rappresenta una grande assunzione di responsabilità – «In fondo, a pensarci bene, abbiamo distrutto quello che non siamo stati in grado di possedere», scrive l’autore nelle pagine finali – un attento memorandum per chi, pur professando il suo amore per Napoli, non riesce ad essere sincero.
